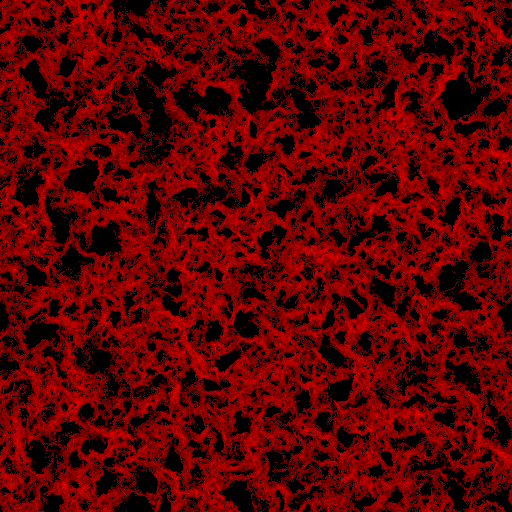Siamo nel 1890.

Supponiamo che un geniale e ispirato musicista
componga la sua opera più bella e la trascriva su uno spartito musicale, e che poi esca di casa, ebbro di soddisfazione, e si rechi nella piazza principale della sua città, e qui affigga sui muri copie manoscritte del proprio spartito per fare conoscere la sua opera alla cittadinanza.
Alcune le lancia dai balconi del palazzo comunale per lasciare che il vento le trasporti ovunque. La sua intenzione è quella di farsi conoscere dal pubblico e far partecipare il maggior numero possibile di spettatori ai suoi concerti a pagamento.
Supponiamo che a quel punto succeda una cosa bizzarra, inaspettata: un bambino con lo sguardo vivace legge in piazza uno spartito e tira fuori dalla propria borsa un foglio e una matita, e lo ricopia. Sorridente, ripone poi foglio e matita nella sua borsa, e se ne va di corsa a casa lasciando lo spartito dove lo ha trovato. Giunto a casa, suona l'opera del musicista una, dieci, cento volte, per il proprio diletto, e per quello dei suoi amici e dei suoi familiari.
A quelli più cari, ricopia lo spartito su un foglio e ne fa dono.
Il bambino suona talmente bene che diversi dei suoi ascoltatori si sentono appagati dell'esecuzione e decidono di non andare ai concerti del musicista.
Nessuno sarebbe neanche sfiorato dall'idea che il bambino abbia rubato l'opera del musicista o abbia commesso un plagio.
Non so quanti di noi si rendono conto che quella che ho appena descritta è la versione ottocentesca di un fenomeno che oggigiorno è diventato assai frequente.
In che misura quel bambino di allora è diverso da un adolescente di oggi che scopre su Internet un un file musicale, e ne scarica una copia sul proprio computer?
In nessuna misura, perché l'adolescente odierno non si è certamente introdotto furtivamente nella casa dell'artista ricopiando uno spartito segreto. Si è limitato a compiere l'equivalente moderno del suo coetaneo ottocentesco che si reca in piazza: ha aperto la propria finestra su Internet, la moderna sconfinata piazza virtuale.
Qualunque opera dell'ingegno destinata ad essere riprodotta in serie (filmati, audio, foto, testi, ipertesti, software) è destinata ad essere comunque convertibile in formato digitale. Qualunque contenuto digitale è inevitabilmente distribuibile in rete, ovvero è quasi automaticamente pubblicabile su Internet. Di più, io dico che la sua natura digitale fa di esso un contenuto già pubblico, in quanto la sua pubblicazione su Internet è scontata, o almeno questa evenienza è rapportata soltanto alla misura del successo e della diffusione di quell'opera, ed è quindi una circostanza puramente probabilistica.
Ignorare questa circostanza oggi è - da parte di autori, editori e distributori - un semplice voler nascondere la testa sotto la sabbia. E voler piegare gli ordinamenti giuridici all'imposizione coatta del divieto di download, copia e riproduzione privata dei contenuti digitali protetti da copyright sembra a me l'equivalente di ordinare l'arresto o l'ammenda per quel bambino di cui si diceva all'inizio di questa riflessione: è insensato, ingiusto, e oltre ad essere una grave limitazione della libertà individuale costituisce anche un costo insopportabile per tutta la società, al solo beneficio di interessi economici costituiti e non più in grado di reggere alla concorrenza.
Più in dettaglio.
Contenuto audio (es. file musicale).Il file audio deve consentirne l'esecuzione,
altrimenti non raggiunge il suo scopo. L'esecuzione di un file audio comporta la lettura dell'informazione, la conversione da digitale ad analogico e la riproduzione attraverso un sistema hi-fi. Questo a prescindere da quale sia il formato originale del file. Con l'avvento di Internet è caduto il monopolio delle major discografiche per la pubblicazione dei CD e per la loro distribuzione, che fino a quel momento costituiva l'unico ostacolo ad una circolazione più libera - e più economica - di musica. La strada dei sistemi DRM (Digital Rights Management) intentata dalle major è una in palese conflitto con le finalità di un file audio, e si è infatti dimostrata fallimentare: la necessità stessa di dovere a un certo punto ricostruire il segnale analogico e riprodurlo su un sistema hi-fi è sempre stato in antitesi rispetto ai propositi del DRM. Il modello di business tradizionale delle case discografiche è obsoleto. La vendita on-line direttamente dagli artisti o attraverso portali musicali, a basso costo, diventerà la nuova realtà. Quello dei CD diventerà un mercato di nicchia, per collezionisti ed appassionati. La circolazione, anche peer-to-peer, dei file musicali sarà libera e consentita, e costituirà il miglior canale per la promozione dei brani musicali - l'equivalente digitale del passa parola, che da sempre è il mezzo migliore per fare pubblicità.
Contenuti video (es. film)L'esperienza di assistere ad una prima visione in una sala cinematografica non può essere sostituita neanche da un buon sistema home-theatre: per questa ragione il mercato del cinema non sta soffrendo come quello della musica. Tuttavia il mercato dei DVD originali ha gli stessi limiti e difetti di quello dei CD musicali, e sta andando incontro allo stesso destino. Soltanto la dimensione decisamente superiore di un DVD sta limitando la diffusione del peer-to-peer, ma chiaramente questo limite è destinato ad essere superato col crescere della diffusione della larga banda e della tecnologia. Se i prezzi dei DVD si assesteranno su livelli più ragionevoli, sarà spesso preferito acquistare un DVD originale per farsi la propria videoteca.
Testi (es. libro).Un file non può certo sostituire il piacere di leggere il libro originale. Questo mercato non è destinato ad andare in sofferenza. I giornali e le riviste, invece, si stanno già adeguando per sfruttare i vantaggi offerti dalla distribuzione on-line dei contenuti agli abbonati. Sono nate riviste specializzate che non avrebbero mai visto la luce se si fossero dovute affidare soltanto alla distribuzione tradizionale.
Dati (es. banche dati)Il valore di una banca dati è dato dall'aggiornamento dei suoi dati. Questo mercato vede in Internet una grande opportunità, non certo una minaccia.
Software (es. programmi applicativi)I software protetti da copyright, rilasciati con l'acquisto di una licenza d'uso, sono minacciati dall'impiego dei sistemi peer-to-peer.
Anche per questi "contenuti" valgono le considerazioni fatte per i CD audio: il modello di business è obsoleto, l'affermazione delle licenze GPL e della concorrenza opensource è lì a dimostrarlo,
anche se ci sarà sempre spazio per programmi di buona qualità ed a basso costo.